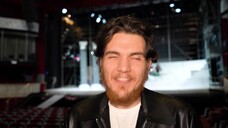I Musei Civici di Venezia, finanziati
al 99% da entrate proprie, sono al primo posto nella classifica
dei musei italiani più virtuosi per grado di autonomia
finanziaria, secondo i bilanci 2019. Sono i dati di un'indagine
su musei e siti culturali pubblici del nostro Paese con le best
practice gestionali proposti nel libro 'Economia della cultura'
(Edizioni Pigreco) di Marco Causi, professore di Economia
Politica all'Università di Roma Tre.
Raggiungono alte percentuali anche il Museo Egizio di Torino
e il Colosseo (88%), la Galleria dell'Accademia di Firenze (81%)
e gli Uffizi (67%), le Residenze sabaude di Torino (66%), Pompei
(65%) e la Galleria Borghese (59%). Tuttavia, non tutti i musei
statali presentano alti livelli di autonomia finanziaria. Nella
maggior parte degli istituti analizzati il livello di gestione
autonoma è inferiore al 35 per cento. Le percentuali più basse
sono in Campania: nel Parco archeologico dei Campi Flegrei (6%)
e nel Museo di Capodimonte (3%).Tra il 2006 e il 2019 l'Italia,
insieme alla Francia, ha conquistato la leadership europea
nell'affluenza ai musei con un incremento del 2,2%- 2,3% in
media ogni anno.
"Il settore della cultura, insieme a turismo, pubblici
esercizi e trasporti, è stato uno dei più colpiti dalla
pandemia. A soffrire sono state soprattutto le attività
culturali dal vivo, dove le nuove prescrizioni di sicurezza
sanitaria eserciteranno una spinta sui costi di produzione.
Bisogna ora capire se e quando la domanda di consumo tornerà ai
livelli precedenti la pandemia e con quali modifiche" dice
Causi.
La 'malattia dei costi' degli spettacoli dal vivo, spiega il
professore di Economia e Politica, può essere curata attraverso
l'uso di nuove tecnologie, l'innovazione dei formati e degli
eventi. Un esempio sono i festival che incontrano sempre un alto
gradimento da parte del pubblico con ricadute economiche
positive sulle città e sui territori. Altre risorse, che
riguarderanno però tutto il settore della cultura e del turismo,
arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: 6,7
miliardi di euro, da spendere entro il 2024, finalizzati
all'accessibilità, fisica e digitale, dei siti culturali, al
recupero dei borghi storici, alla tutela e alla valorizzazione
dell'architettura e dei paesaggi rurali.
Un altro piano di azione riguarda le famiglie. In Italia i
tassi di partecipazione culturale sono diversificati sul
territorio: la spesa media per consumi culturali di una famiglia
del Nord è pari a quasi il doppio di quella nelle regioni nel
Sud e supera del 30% quella delle regioni centrali. Percentuali,
comunque, basse rispetto alle medie europee.
Il testo, pensato per gli studenti delle Università e dei
corsi di master e specializzazione in economia e gestione dei
beni e delle attività culturali, è accessibile a tutti ed è
corredato da un ampio apparato informativo, statistico e da casi
di studi italiani, europei e internazionali. Uno di questi è
quello della Cina dove, negli anni precedenti la pandemia, gli
ingressi museali erano circa 1,2 miliardi l'anno, 14 volte in
più rispetto al 2000 e più che raddoppiati rispetto al 2010.
Il libro sarà presentato a Roma, il 15 giugno al Maxxi alle
18.30, alla presenza dell'autore, con interventi della
presidente del Maxxi Giovanna Melandri, del presidente e
sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia Michele
dall'Ongaro, della direttrice del Master in Economia e gestione
dei beni culturali dell'Università di Roma Tre Michela
Marchiori, la deputata e membro della commissione Cultura,
Scienza e Istruzione Flavia Piccoli Nardelli, il direttore della
rivista Economia della Cultura Pietro Antonio Valentino e la
direttrice della Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali al ministero della Cultura Alessandra Vittorini.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA